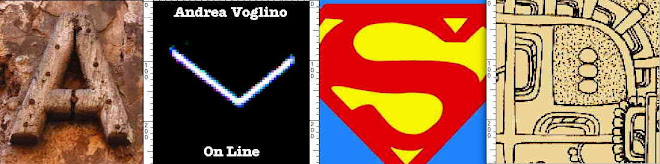Seriamente: è un film che parla di una semidea nata sull’isola che non c'è, allevata da una schiatta di amazzoni e in grado di sollevare un tank come fosse un giocattolo. Il punto non sta nell’aderenza al mito o alla Storia, peraltro già piuttosto laschi di loro, data la necessità di condensare settantacinque anni di fumetti non sempre eccezionali in due ore di film. Semmai, ha a che fare con l'equilbrio fra i due estremi noia/divertimento, vista la dieta forzuta e forzata di pellicole super-eroistiche cui le major ci stanno abituando ultimamente. E a scanso di equivoci, Wonder Woman la sua parte pallosetta ce l'ha: il finalone fine di mondo a base di sganassoni con un cattivo che il casting avrebbe voluto sorprendente e invece suona sorprendentemente fuori contesto e carismatico quanto un boss di God of War. Ma questo è un destino comune al 90% dei cinefumetti, non un'esclusiva del nuovo film Warner.
Per il resto, aurea mediocritas, con una pellicola che sembra un curioso mashup fra Capitan America – Il primo vendicatore, Animali Fantastici e un classico feuilleton amore e guerra tipo Vite sospese. Gal Gadot è davvero uno spettacolo e regala al personaggio bellezza, carisma e simpatia: non era scontato. Ma al lasso dorato e ad altre bubbole terribilmente agre disseminate lungo le due ore e venti del film paiono crederci poco sia la protagonista, sia il cast di contorno, sia la regista Patty Jenkins, che infatti qua e là offre al pubblico un certo non so che di “buona la prima”. Sprazzi di divertimento puro nel cast multietnico, nelle schermaglie con il bellimbusto Chris Pine, nei bassifondi di Londra. E qua e là, qualche stecca che le pennellate da commedia sentimentale sintoniche al personaggio e al film non bastano a nascondere.
Fosse capitato in mano a un regista di forte personalità, Wonder Woman sarebbe potuto diventare una chicca. Così com’è, resta un compitino beneducato, superficiale e non sempre perfettamente a fuoco. Che però ha il merito principale di aver dato un senso nuovo a un personaggio decrepito e fiaccato da decenni di brutta televisione. Di buono, portiamo a casa le premesse per una cosiddetta brand extension che con un po’ di coraggio e visionarietà in più potrebbe fruttare sviluppi narrativi interessanti, sempre che il pubblico segua. Chi si straccia le vesti potrebbe guardare a questo, piuttosto che ai difetti del film: rispetto ai telefilm con Lynda Carter o all’orribile Catwoman di Pitof, il bicchiere è mezzo pieno. Un brindisi ci sta.