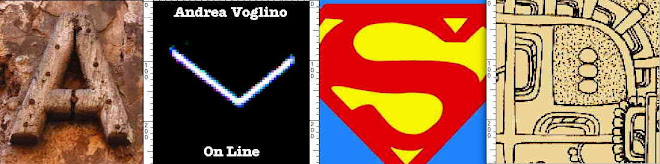|
| L'uscita è di là |
Per quanto sembri incredibile, la storia gloriosa di
Star Wars è costellata di clamorosi strafalcioni. A commetterli, un'autentica
Hall of Fame del cinema mondiale: da Francis Ford Coppola, che sconsigliò vivamente a George Lucas di investire in quella che considerava un'autentica follia; al leggendario Al Pacino, che rifiutò sdegnosamente il ruolo di Han Solo; fino ai tecnici della nascente ILM, incapaci di dare una forma minimamente accettabile alle visioni spericolate del regista di Modesto, California. Altre cappelle in ordine sparso, tutte clamorose: quella della 20th Century Fox, che accettò di cedere al demiurgo della saga i diritti sul merchandising temendo - quasi sperando - in un flop; quella della MEGO corp,, che rifiutò di inserire Luke & C. fra le fila della sua linea di
Action Figures, passando il testimone alla Kenner, che di lì a poco l'avrebbe seppellita; e forse, anche quella più recente di Lucas, arrivato a un passo dal fallimento per consegnare ai posteri Jar-Jar Binks e i Midichlorian.
Quattro miliardi di dollari dopo, il testimone delle cazzate è passato alla Casa del Topo, che dopo essersi svenata per portarsi a casa tutto il malloppo - diritti intellettuali, licenze, dirigenza e infrastrutture - giustamente pensa bene di spremere i fan della saga fino all'osso. Lucas consigliava di lasciar perdere i vecchi e affidare la lotta fra bene e male alle nuove leve. La Disney, invece, ha avuto fretta di capitalizzare. E quindi: un (orribile) remake sotto mentite spoglie del film del 1977, completo di cast originale, tanto per mettere d'accordo tre generazioni di spettatori; più un sacco di "invenzioni" a zero potenza d'impatto, ma perfette per tirarci fuori modellini e pupazzetti. Un'altra cazzatona, insomma. Però figlia del più puro cinismo.
È a partire da questa premessa che bisogna guardare al film firmato da Rian Johnson. Perché strillare alla lesa maestà va bene solo a prescindere da questo excursus. E chi rimpiange i bei vecchi tempi che forse non sono mai esistiti non ricorda o finge di non ricordare che il mitico Main Theme di John Williams altro non è che un plagio bello e buono dello score di Erich Korngold per
King's Row (1942), il design di Ralph McQuarrie pescava a piene mani dal Druillet di
Lone Sloane, e il primo commento di Harrison Ford al copione fu qualcosa del tipo
"Tu avrai pure scritto tutta 'sta bullshit, George, ma non credere che io sia in grado di recitarla".
Chi è senza peccato etc. etc.
È totalmente inedito,
Star Wars episodio VIII - Gli ultimi Jedi? No. È una specie di remake più articolato, quasi barocco, di
L'Impero colpisce ancora, con in più una regia piatta - oggi diremmo
serviceable - quasi quanto quella di Irving Kershner. Che però aveva alle spalle tanto cinema drammatico e sentimentale, quindi un occhio ideale per il suo
Star Wars. È inattaccabile? Ma neanche per sogno: cast assemblato secondo Cencelli della multietnicità, a includere sinoamericani e
latinos, e tanti pupazzetti; gag non sempre a modino; Un atto centrale davvero lungo e stiracchiato; e un cadavere eccellente davvero sprecato (no, non quello lì, siamo dalle parti di metà film). Ma a ben guardare, questi sono difetti tipici di tanto cinema recente, e anche di quella
galassia lontana lontana. La buona notizia è che stavolta il catalogo delle agnizioni, dei cambi di casacca e dei disvelamenti recupera la gravitas da feuilleton post-pop dei momenti più coinvolgenti della serie, compiendo il miracolo di un paio di sequenze di guerra stellare discutibili sotto il punto di vista strategico ma godibilissime, di un finale tutto in crescendo e di una riscrittura molto junghiana del vero punto cardinale della nuova trilogia, il
ti-vedo-non-ti-vedo fra l'aspirante Jedi Rey e il cosplayer di Darth Vader Kylo Ren. L'amorale della fava è che per costruire un mondo nuovo bisogna prima lasciarsi alle spalle quello vecchio, anche se si tratta di una mission lacrime e sangue per tutti, spettatori compresi. Metacinema puro, visto il pieno rispetto del "modello Marvel" in tema di budget e controllo produttivo. Ma al di là di quanto scritto qui sopra, si esce dal cinema con un senso di sazietà e aspettativa che al pur meglio diretto
Il risveglio della Forza mancava totalmente. Bene così.